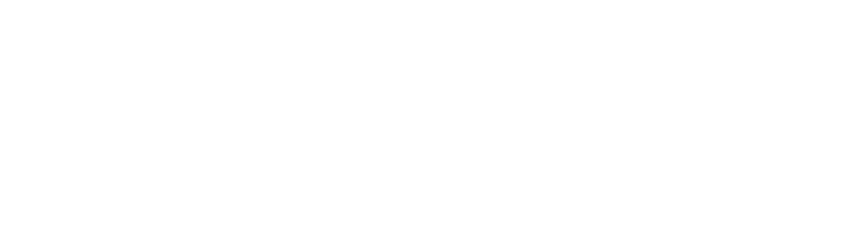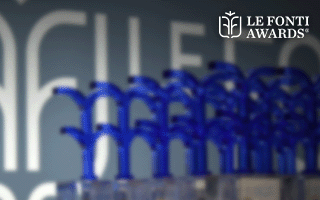L’attenzione a responsabilità sociale e a pratiche a basso impatto ambientale premia. In termini di brand reputation e di abbattimento dei costi. Lo sostengono i vertici di imprese e studi legali
[auth href=”http://www.worldexcellence.it/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]Essere innovativi e sostenibili premia. In termini di brand reputation e a livello di costi che pratiche tecnologicamente avanzate e socialmente responsabili aiutano ad abbattere. È quanto emerso dal Le Fonti Ceo Summit tenutosi il 23 giugno a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano in occasione della seconda serata dei Le Fonti Awards. Al dibattito dal titolo «Leadership e innovazione per una crescita sostenibile», moderato da Angela Maria Scullica, direttore delle di World Excellence e Legal, hanno partecipato: Angelo Trocchia, presidente e amministratore delegato di Unilever Italia, Luca Failla, founding partner di LabLaw, Domenico Simone, membro del Cda di Menarini, Massimo Bartolini, presidente e Ad di Multivendor Service, Riccardo Agostinelli, name partner dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e Gaetano Grizzanti, Ceo e founder di Univisual Brand Consulting. Dopo l’iniziale diffusione in Nord America e in Europa, anche in Italia si inizia a discutere, con maggior interesse rispetto al passato, di social innovation e di Csr (responsabilità sociale d’impresa) come driver per la nostra economia. E non solo in virtù della normativa e dei vincoli imposti dalle istituzioni. Si tratta di una tipologia di innovazione capace di creare nuovi saperi tecnici o organizzativi, di un approccio manageriale ai problemi sociali, dell’utilizzo di tecnologie, strumenti, forme organizzative finalizzate a creare attività imprenditoriali partendo da una socialità di rete. L’innovazione sociale chiede infatti idee, creatività, coraggio, metodologie inedite per trasformare principi teorici e ricerca accademica in prodotti e servizi da offrire a un mercato sempre più attento ai bisogni delle persone e alla sostenibilità.
La sostenibilità all’interno del piano di business. È quanto multinazionali come Unilever affermano da alcuni anni. E i risultati sembrano dar loro ragione. «Per un’azienda come la nostra diffusa in 190 Paesi e con due miliardi di consumatori al giorno il tema della sostenibilità è fondamentale per sviluppare il business», ha dichiarato Angelo Trocchia di Unilever Italia. Non è solo una questione di facciata, di window dressing. «Per noi sostenibilità significa accrescere il business in maniera responsabile, riducendo l’impatto sull’ambiente, ma soprattutto agire sul consumatore per far sì che cambi le proprie abitudini di consumo in virtù di assicurare una sostenibilità futura». Trocchia ha citato alcune ricerche secondo cui anche in Italia, dopo un primo grande sviluppo in Stati Uniti e Nord Europa, i clienti siano oggi estremamente sensibili a questi temi. «Abbiamo iniziato questo percorso nel 2010: le materie prime in Europa vengono quasi per il 100% da fonti sostenibili e tutti i nostri stabilimenti in Italia hanno ridotto a meno del 30% negli ultimi tre anni l’emissione di co2. La riduzione dell’impatto ambientale abbatte poi i costi della supply chain. E il consumatore ci dà ragione: in Italia e nel mondo i marchi che hanno fatto della sostenibilità un messaggio concreto all’interno del dna del brand stesso, stanno crescendo almeno due volte rispetto agli altri».
La business identity passa dal brand. L’integrazione al proprio brand di pratiche etiche non è tuttavia un’operazione semplice. «Occorre partire dal concetto di business identity», ha precisato Gaetano Grizzanti di Univisual. «Il brand non è infatti il logo, né il prodotto, né l’azienda stessa. È un’entità particolare che viene oggi quantificata economicamente. È il brand che fa decidere alle persone di spendere, ad esempio, mille euro per un telefono. Il brand sposta la realtà delle cose. Bisogna capire dove fare leva». Secondo Grizzanti un’impresa, di qualsiasi settore, deve fare i conti con la necessità di rendere credibile che il suo prodotto o il suo servizio siano migliori di quelli degli altri. «Tutti abbiamo concorrenti», ha proseguito. «Riuscire a trasformare per ogni organizzazione il proprio marchio in una marca, cioè in un’entità che dà il vero valore aggiunto a un’offerta, oggi è un po’ la chiave non solo della sopravvivenza, ma anche dell’evoluzione di un’impresa e della sua cultura: riuscire ad avere una marca per qualsiasi attività significa integrare valore economico-finanziario ma anche di percezione, perché oggi non siamo nell’era della realtà, ma nell’era della percezione».
Alto valore per la collettività e il territorio. Ci sono realtà come Menarini che hanno deciso di puntare su iniziative di responsabilità sociale all’interno della propria sede centrale, creando un asilo nido aziendale aperto anche alla cittadinanza e ristrutturando alcune abitazioni nel comune di Firenze. Per poi spaziare, a livello nazionale, alle innovazioni nel campo della ricerca farmaceutica fino alle apparecchiature di avanguardia. «Si tratta di progetti che portiamo avanti per anni e per noi devono avere due caratteristiche: essere destinati a fasce deboli e durare nel tempo, perché la sporadicità degli interventi non porta a nulla», ha spiegato Domenico Simone, membro del Cda di Menarini. Negli ultimi mesi il gruppo farmaceutico si è dedicato ad un altro grande progetto destinato al mondo dell’infanzia in collaborazione con Telefono Azzurro e numerose associazioni di ospedali e medici pediatri. «Annualmente in Italia oltre 70mila bambini vengono abusati fisicamente, mentalmente o anche sessualmente e solo pochi casi emergono e vengono scoperti. Il nostro presidente, Lucia Leotti, particolarmente sensibile a queste tematiche, ha deciso col fratello di creare un progetto per addestrare 15mila medici, definiti “medici sentinella” perché siano in grado di riconoscere i primi segnali di qualsiasi tipo di violenza venga esercitata sui minori. È la prima iniziativa al mondo di questo genere e ci auguriamo abbia successo».
Una rivoluzione che parte dall’Italia. L’Italia è in prima linea anche per la sperimentazione di nuovi prodotti su scala globale. La creazione da parte di Philip Morris Italia del nuovo sito di Crespellano (Bologna) che porterà all’occupazione di oltre 500 persone, rappresenta uno degli investimenti più ingenti nell’ultimo anno da parte di una multinazionale straniera nel nostro Paese. Si tratterà del primo stabilimento al mondo per la produzione di nuovi prodotti del tabacco. «Sono diversi anni che la società investe in ricerca e sviluppo, ricorrendo persino a nano tecnologie e robotica, per realizzare una nuova categoria di prodotto che non vive più di combustione ma di induzione, quindi di riscaldamento indotto. Senza la combustione non vengono generati più i componenti tossici normalmente associati alle sigarette», ha spiegato Eugenio Sidoli, presidente e ad di Philip Morris Italia. «Crediamo che sia una rivoluzione nel nostro settore, una rivoluzione che sarà rilevante per il miliardo e 300 milioni di fumatori al mondo e che parte da Bologna. La società ha infatti deciso di investire una cifra significativa per la costruzione di un impianto pilota, il primo e il più importante su scala globale per la produzione di questo nuovo prodotto. Un investimento molto significativo perché è in Italia, e questo è un motivo di soddisfazione per me e per tutti quelli che credono che il nostro Paese nel campo dell’innovazione abbia molte cose da offrire». La multinazionale del tabacco è presente a Bologna da 50 anni, terra famosa per la meccanica di alta precisione e per le biotecnologie. «È un territorio che ci offre tantissimo per poter portare avanti un progetto con il quale pensiamo di guadagnare dall’Italia una buona fetta di mercato mondiale».
Sguardo all’estero anche nel labour. Se le multinazionali guardano nostro Paese, le imprese italiane si spingono sempre di più verso l’estero attraverso percorsi di internazionalizzazione. Da qui la necessità di un supporto, anche legale, che ha spinto gli avvocati ad assumere in maniera crescente i panni del consulente strategico al fianco dell’impresa. «La nostra professione è cambiata. Da professionista artigiano e da studio boutique anche l’avvocato italiano ha mutato il pro prio ruolo e funzione ed è diventato sempre più un consulente e un partner delle aziende con cui crea valore aggiunto in un rapporto continuo che riesce ad arricchire l’attività di business», ha illustrato Luca Failla di LabLaw. «Abbiamo così potenziato la nostra attività verso l’internazionalizzazione trasformando una delle branchie del diritto più locale, in qualcosa che non lo è, attraverso la creazione di partnership straniere. Un’attività inbound che c’è sempre stata». In genere l’Italia è stata da sempre un Paese che attira le richieste di consulenza provenienti dall’estero, ma creando un’offerta outbound. «Da una decina d’anni a questa parte la nostra è un’attività di diritto del lavoro che si svolge in buona misura all’estero», ha aggiunto il founding partner. «Ci sono delle realtà italiane che hanno fatto dello sviluppo all’estero un importante fattore del proprio sviluppo e del proprio successo. Noi assistiamo queste aziende dall’Italia all’estero attraverso un’alleanza internazionale di partner di altissimo profilo».
L’innovazione dell’ultimo miglio. Ci sono dei settori che necessitano di vedere colmati alcuni gap per poter risultare competitive nel mercato globale. Soprattutto in termini di efficienza e della cosiddetta innovazione dell’ultimo miglio. «Oggi “l’ultimo miglio” rappresenta gioie e dolori di tante organizzazioni, istituti bancari, compagnie assicurative, grande distribuzione, negozi che fanno attività al dettaglio, che devono per forza presidiare il territorio nazionale», ha evidenziato Massimo Bartolini, presidente e ad di Multivendor Service. «I clienti ci chiedono che la tecnologia non rappresenti un problema perché non fa parte del loro core business. Da qui la necessità di implementare la nostra offerta: noi abbiamo circa 700 tecnici itineranti sul suolo italiano e 200 di presidio, tutti coordinati da circa 300 persone. E grazie a loro gestiamo circa 48 mila postazioni di lavoro, 120 mila postazioni di stampa e 18 mila device di mobility». Numeri impensabili senza un costante aggiornamento ai dettami della tecnologia. «Oggi ad aziende come la nostra viene richiesto di intervenire ancor prima che la difficoltà si presenti», ha confessato Bartolini. «Così all’interno della nostra suite di soluzioni ne sono state introdotte alcune capaci di farci percepire il problema prima ancora che nasca». Solo anticipando eventuali complicazioni si può essere leader di mercato, anche in settori considerati tradizionalmente fiaccati dalla burocrazia e poco inclini all’innovazione, come la Pubblica amministrazione. «Recentemente abbiamo installato, in un progetto previsto in 500 comuni italiani, la prima apparecchiatura tecnologica per stampare la carta d’identità digitale in partnership con la Fujitsu e il dipartimento servizi di Hewlett Packard Enterprise».
Il private equity per finanziare la crescita. Per innovare le imprese devono anche investire e hanno bisogno di fondi. L’Italia, in linea con le direttive europee, sta lentamente allontanandosi dal sistema bancocentrico che per anni ha dominato la struttura economico finanziaria del Paese. In questo contesto in evoluzione le piccole e medie imprese italiane sembrano infatti ancora spesso temere gli investitori stranieri e ignorare le nuove forme di investimento. «Il private equity sta ritornando in maniera molto robusta in questi ultimi mesi», ha illustrato Riccardo Agostinelli dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. «C’è un lato oscuro del private equity, emerso durante la crisi, che non ama le imprese e distrugge valore: è quello che crea una leva eccessiva e finisce per spingerla con il metodo del push down del debito sulle imprese che si trovano quindi soffocate da un debito non correlato allo sviluppo dell’azienda stessa. In realtà un fondo di private equity, sia di maggioranza sia di minoranza, può aprire le imprese a nuove opportunità, a nuovi mercati, può creare sinergie con le portfolio companies, può dare nuove entrature». Quando un investitore guarda a un’azienda per misurarne il valore, tra i primi aspetti ad essere considerati c’è l’eccesso o meno di concentrazione di fatturato su un determinato mercato. «In tal senso l’internazionalizzazione è sempre buona», ha aggiunto l’avvocato. «Un altro aspetto riguarda il fatto che le imprese sono magari delle eccellenze, ma soffrono di una gestione troppo padronale. Il private equity potrebbe portare nuova tecnologia e una innovativa modalità di gestione. Terzo e ultimo aspetto: può essere una soluzione al problema del passaggio generazionale. Non tutte le famiglie sono formate da imprenditori: possono esserci anche competenze e aspirazioni diverse. Il private equity potrebbe rappresentare un’importante soluzione a questo problema».
[/auth]