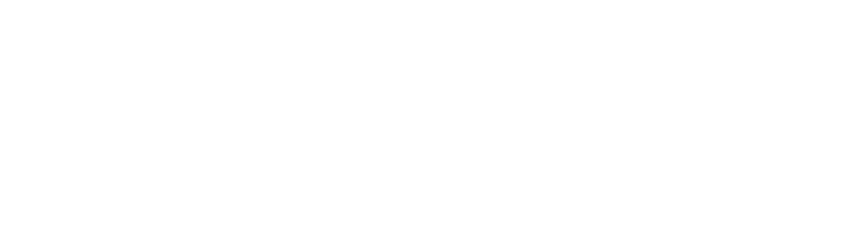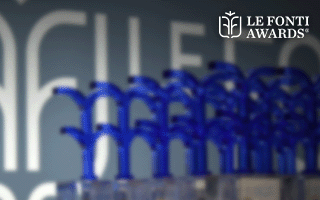La crisi ha accelerato il processo di integrazione europea. Ma ne ha anche esaltato diffidenze e ostacoli. E ora, per continuare il cammino, l’Europa deve dare risalto a un sistema di sentimenti profondi e aspirazioni nel quale i diversi popoli dell’Unione si riconoscano e si identifichino
[auth href=”http://www.worldexcellence.it/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]Il processo di integrazione partito con l’euro sta attraversando oggi una fase di profondo ripensamento intellettuale. Per troppo tempo infatti si è ritenuto che la creazione di una moneta unica e l’unificazione dei mercati economici e finanziari bastassero da soli a far convergere i singoli Stati in una grande area europea uniforme, coesa e democratica.
D’altra parte i vantaggi di un’Europa unita, che ha cominciato a prendere forma dalla fine della seconda guerra mondiale (e che ha avuto un’accelerazione in seguito alla crisi di questi anni) erano evidenti agli occhi di molti.
Una moneta unica, l’euro, e un sistema legislativo condiviso di diritti e doveri, uguale per tutti, avrebbero infatti potuto favorire la libera circolazione di idee, capitali, beni, servizi con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate in termini di crescita e benessere diffuso. L’evoluzione stessa della tecnologia che ha reso il mondo collegato e interrelato e la globalizzazione dei mercati spingevano in questa direzione.
Un percorso che la crisi iniziata nel 2007, come si sa, ha da un lato accelerato sul fronte economico e finanziario e dall’altro reso molto più fragile e complesso. Se infatti all’inizio del cammino europeo era opinione diffusa che il fatto stesso di adottare un’unica moneta sarebbe di per se stesso stato sufficiente, o comunque avrebbe costituito una buona base di partenza, per creare un’area economica e finanziaria integrata, il prolungarsi della crisi, aggravato dall’ondata migratoria senza precedenti dovuta all’instabilità del Nord Africa e del Medio Oriente, sta dimostrando la fragilità di questo assunto.
La crisi ha messo in evidenza non solo carenze nelle strutture istituzionali a sostegno dell’Unione economica e monetaria, ma anche nelle motivazioni. È a partire dal 2010 che la situazione cominciò in Europa a degenerare, da quando cioè vennero a galla le debolezze della Grecia. Da allora tutte le misure prese per arginare il fenomeno evitandone le peggiori conseguenze sono state decise e avviate in un clima di emergenza che ha richiesto una grande velocità di intervento. La gravità della situazione innescò infatti una profonda crisi di fiducia sulla possibilità del governo greco di restare insolvente. Nei mesi seguenti le agenzie di rating abbassarono i rating dei titoli greci a livello di titoli spazzatura. Decisione che fece schizzare in alto i tassi di interesse greci e lo spread rispetto ai Bund tedeschi.
Per evitare il default, la Grecia si impegnò con la Commissione europea e il Fmi ad adottare drastiche misure di risanamento fiscale. Ma il contagio ai Paesi europei, che presentavano cioè debiti pubblici peggiori e prospettive di crescita bassa, era diventato ormai irrefrenabile. Così subito dopo la Grecia entrarono in crisi Irlanda, Portogallo, Spagna e infine Italia.
I mercati sembravano impazziti e per calmierare una situazione che stava ormai sfuggendo di mano tutti i Paesi furono costretti ad adottare misure di risanamento fiscale. In quelli a maggiore rischio di default, oltre ai tassi che lievitavano verso l’alto, aumentarono anche i premi pagati dai detentori dei titoli di Stato per assicurarsi contro la possibile insolvenza tramite lo strumento dei Cds. Ciò fece crollare il valore dei titoli di Stato che erano per la gran parte detenuti dalle banche. E le conseguenze per le banche furono pesanti: mentre l’attivo perse valore, salì il loro rischio di insolvenza e precipitarono le loro quotazioni di Borsa.
Così la crisi, nata dalle banche, passò agli Stati sovrani, e ritornò alle banche, che si trovarono nella situazione di dover ricapitalizzare, con la difficoltà di trovare finanziamenti, poiché anche gli Stati stavano riducendo i loro deficit.
L’Unione bancaria nacque in Europa nel clima di emergenza generato dalla crisi dei debiti sovrani. È stata, insieme alle politiche di quantitative easing della Bce, la risposta più immediata al contagio delle gravi bolle speculative che minacciavano la tenuta dell’Unione europea.
C’è infatti un legame molto forte tra le banche e gli Stati nazionali. Queste investono in titoli pubblici del loro Paese e, se i tassi salgono, registrano da un lato perdite in bilancio e, dall’altro, si trovano a pagare di più la raccolta di fondi all’ingrosso.
L’Unione bancaria è sorta dall’idea di sottrarre agli Stati nazionali la gestione delle banche in difficoltà per portarla in Europa in modo da calmierare la situazione evitando manovre speculative che avrebbero potuto mettere in gioco i sistemi nazionali.
In molti Paesi erano dilagate crisi bancarie di varia natura per ragioni che andavano dallo scoppio di bolle speculative immobiliari (Spagna e Irlanda), al contagio di strumenti tossici di finanza strutturata (Germania). In Italia la perdurante recessione e scarsa crescita, aveva fatto scoppiare il problema delle sofferenze.
A differenza di quelle italiane che cercarono prevalentemente di cavarsela da sole, le banche europee ricorsero agli aiuti pubblici che si esaurirono nella prima parte del 2013. Così, nel luglio di quell’anno, la Commissione europea si trovò costretta a emanare una Comunicazione in tema di disciplina degli aiuti di Stato vincolante in tutti i paesi. In essa si stabilì che da quel momento gli aiuti erano ammessi solo a condizioni molto stringenti e previa condivisione dell’onere da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati: un principio somigliante a quello del salvataggio dall’interno, bail-in, posto al centro della nuova disciplina europea delle crisi bancarie che si andava preparando.
La crisi delle banche spinse anche ad accelerare la strada verso l’integrazione e il rafforzamento del mercato dei capitali con l’obiettivo di accrescere le fonti di finanziamento per le imprese al di fuori dei canali bancari e di consentire ai fondi di affluire direttamente agli utilizzatori finali attraverso il mercato, saltando quindi l’intermediazione bancaria.
Il 29 gennaio 2015 la Commissione Junker lanciò il progetto per la realizzazione di un mercato unico dei capitali a livello europeo, volto a porre le basi per un’unione, oggi molto frammentata, dei mercati dei capitali dei 28 Stati membri entro il 2019 (27 dopo la Brexit).
Il 22 giugno 2015 il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Vertice euro, Donald Tusk, il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, presentarono un piano ambizioso per approfondire l’Unione economica e monetaria (Uem). La relazione, cosiddetta dei cinque presidenti, «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», ha tracciato un percorso nel quale si distinguono due fasi temporali, e quattro pilastri (Unione economica, finanziaria, di bilancio, politica).
La prima fase che andava dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2017 prevedeva, tra le altre cose, il completamento dell’Unione finanziaria e bancaria con l’istituzione di un meccanismo di finanziamento ponte per il Fondo unico per la risoluzione delle crisi e il sistema comune di garanzia dei depositi; la possibilità di ricapitalizzazione diretta delle banche utilizzando il Meccanismo europeo di stabilità (European stability mechanism, Esm); l’avvio della costruzione dell’Unione dei mercati dei capitali, per diversificare le fonti di finanziamento dell’economia; la seconda fase che va dal luglio 2017 al 2025 prevede il completamento dell’Unione economica e fiscale per arrivare a quella politica. Molto si è dunque fatto per affrontare le carenze istituzionali, vanno ora decisamente affrontate le carenze motivazionali.
Sotto i colpi di una perdurante stagnazione, di un’ondata migratoria senza precedenti, di un riassesto degli equilibri mondiali, l’opinione pubblica appare sempre più distante e prevalentemente focalizzata su problematiche di breve termine.
Il caso della Brexit prima, quello recente delle richieste di indipendenza della Catalogna, ma anche gli esiti delle votazioni in Germania che hanno visto avanzare la destra conservatrice e aumentare il vigore dei partiti populisti, fanno riflettere.
Nei singoli Stati si rafforza la voglia di autonomia mentre diminuisce l’identificazione in un’Europa che sembra chiedere ai più sforzi e sacrifici senza dare molto, o nulla, in cambio. Dai dibattiti e dai confronti odierni, sembra emergere chiara l’idea che l’unificazione delle economie e dei sistemi finanziari da sola non basta a creare coesione e voglia di costruire insieme un’entità europea che oltrepassi e abbatta i confini nazionali.
Va prendendo coscienza che questo processo di integrazione richieda non solo la comunione di beni e servizi ma anche l’identificazione di un sistema di valori che superi le differenze storiche e culturali dei popoli e le loro peculiarità. Per dare un senso di appartenenza a popoli diversi per storia, lingua e tradizione occorre infatti individuare quei valori comuni che stanno alla base delle nostre culture e radici storiche.
Una identificazione che scaturisce dalla comprensione e dal rispetto delle diversità culturali, identità e memorie dei singoli Stati. È da questo approfondimento che possono emergere infatti quei valori condivisi a cui le guerre e i conflitti del passato non hanno impedito di diffondersi e di radicarsi in profondità negli animi e nelle coscienze di tutti.
Così una palese ed esplicita dichiarazione dei valori comuni dei popoli, in cui ci si possa identificare e trovare un senso di appartenenza, diventa oggi, nel momento più critico per l’Europa, segnato dall’ingente flusso migratorio che arriva dal medio oriente e dell’Africa, la grande sfida strategica per affrontare quella profonda e radicale evoluzione sociale e culturale che la tecnologia digitale, l’intelligenza artificiale e l’economia della condivisione stanno provocando.
[/auth]